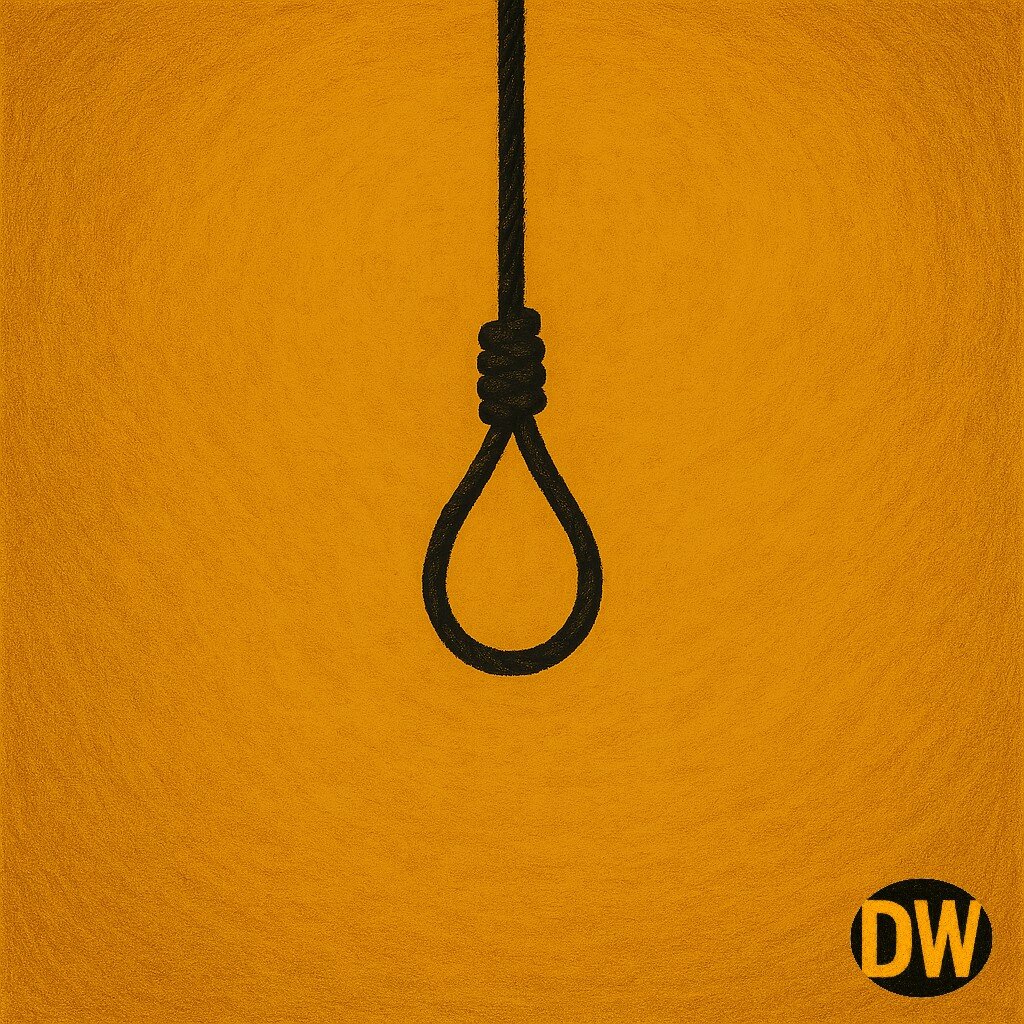«A causa di una particolare debolezza della natura umana si attribuisce, in genere, soverchia importanza a ciò che uno rappresenta, vale a dire a ciò che noi siamo nell'opinione altrui; anche se, per poco che riflettessimo, comprenderemmo che ciò non è, in sé, rilevante ai fini della nostra felicità. Perciò è difficile spiegarsi come mai ognuno si rallegri entro sé ogni volta che avverte negli altri qualche segno di un'opinione favorevole, e che la sua vanità si sente, in un modo o nell'altro, lusingata. Come il gatto, quando uno lo accarezza, fa, immancabilmente, le fusa, così, quando uno viene lodato per qualcosa che riguarda ciò in cui si professa capace, gli si dipinge sul volto una soave voluttà, né importa se quelle lodi sono palesemente mendaci. Spesso i segni dell'altrui plauso lo consolano di un concreto insuccesso o del fatto che sono avare, per lui, le due fonti principali della nostra felicità di cui si è discorso finora [in Aforismi per una vita saggia, nda]; e, viceversa, fa meraviglia osservare quanto, immancabilmente, lo offendano e, spesso, lo affliggano profondamente, ogni ferita inferta al suo orgoglio, in qualunque senso e misura e a qualunque proposito, e ogni manifestazione di disistima, ogni declassamento, ogni mancanza di riguardo. […] Perciò, dal nostro punto di vista, è consigliabile contenere le manifestazioni di un carattere come quello, e, in base a opportune riflessioni e a una corretta valutazione dell'importanza dei vari beni, moderare il più possibile la sua grande sensibilità all'opinione altrui, e ciò sia quando essa ne sia lusingata sia quando ne sia offesa; perché l'una e l'altra cosa pendono dal medesimo filo; altrimenti, si rimane schiavi delle altrui idee e dell'altrui opinione. […]
Contribuirà, quindi, grandemente alla nostra felicità una giusta valutazione dell'importanza che ha ciò che si è in se stessi e per se stessi in confronto con ciò che si è soltanto agli occhi di altri. Ciò che si è in noi stessi è rappresentato dall'impiego del tempo della nostra esistenza, e dai contenuti di quell'esistenza; quindi, da tutti i beni di cui si è detto trattando di «ciò che uno è» e di «ciò che uno ha»; e infatti la sfera d'azione di tutto ciò coincide con la nostra coscienza. All'opposto, sede di ciò che siamo per gli altri è la coscienza altrui; e ciò che siamo per gli altri è la nostra rappresentazione all'interno di essa, insieme con i criteri di giudizio a essa applicati. Si tratta, qui, di qualcosa che non ci si presenta direttamente, ma solo indirettamente, e cioè in quanto determina il comportamento degli altri nei nostri confronti; e anche quest'ultimo, veramente, ci interessa soltanto in quanto influisca su qualcosa che possa modificare ciò che siamo in noi e per noi. Del resto, quanto accade in una coscienza altrui è per noi, in sé, indifferente; e noi stessi finiamo per disinteressarcene a mano a mano che giungiamo a conoscere abbastanza la superficialità dei pensieri che albergano nella grande maggioranza dei cervelli, la limitatezza delle loro idee, la moltitudine dei loro errori, la meschinità degli animi e la falsità delle opinioni; e che impariamo, per esperienza personale, con quanto disprezzo, occasionalmente, si parla di ognuno non appena non si ha più motivo di temerlo, o quando si crede che non lo verrà a sapere; soprattutto, poi, dopo che abbiamo sentito una mezza dozzina d'imbecilli parlare sprezzantemente del più grand'uomo. […]
Infatti, alla base del nostro essere, e quindi della nostra felicità, c'è la nostra natura animale; e perciò, per il nostro benessere, la cosa più essenziale è la buona salute; subito dopo vengono i mezzi necessari al nostro sostentamento, quanto basti, cioè, per vivere senza preoccupazioni. L'onore, il fasto, il rango, la fama, per grande che sia il valore che tanti attribuiscono a beni come quelli, non possono competere con quei beni essenziali, né sostituirli: anzi, all'occorrenza, vi si rinuncerebbe, per avere in cambio questi ultimi, senza alcuna esitazione. Dobbiamo renderci conto per tempo – e ciò contribuirà alla nostra felicità – di una semplice verità: ciascuno vive, prima di tutto e realmente, dentro la propria pelle, e non già nell'altrui opinione; e perciò la nostra reale e personale situazione, quale è determinata dalla salute, dal carattere, dalle attitudini, dalle entrate, da una moglie, dai figli, dagli amici, dal luogo dove abitiamo, e così via, è, ai fini della nostra felicità, mille volte più importante di ciò che gli altri si degnano di pensare di noi. [...]
Se, invece, si vede come quasi tutto ciò a cui gli uomini tendono instancabilmente per tutta la vita, con sforzi indefessi e fra mille pericoli e travagli, ha per fine ultimo quello di salire nell'altrui opinione – perché non solo le cariche, i titoli, le onorificenze vengono ricercati, in fondo e soprattutto, a quel fine, ma anche le ricchezze, e perfino il sapere e l'arte, e il fine ultimo a cui si mira è quello di salire nella considerazione altrui – se si guarda a ciò, si constata che il tutto, purtroppo, dimostra soltanto quanto sia grande la stoltezza umana. Dare troppa importanza all'opinione altrui è un errore universalmente diffuso; che abbia radici nella nostra stessa natura o sia una conseguenza della vita sociale e della civiltà, esso esercita su tutti i nostri comportamenti un'influenza assai esagerata, che è nemica della nostra felicità. [...]
Quello stolto errore, comunque, offre un comodo appiglio a coloro che debbono dominare gli uomini o dirigerli in un modo o nell'altro; e perciò, in ogni specie di addomesticamento degli uomini, ha un posto di primo piano la norma che impone di mantenere vivo e di rafforzare, in loro, il senso dell'onore. Ma per quanto concerne la felicità delle persone – che è ciò di cui ci stiamo occupando – le cose stanno in tutt'altro modo; e il consiglio da dare è, piuttosto, quello di non dare troppa importanza all'opinione altrui. Se, tuttavia, come ci insegna l'esperienza quotidiana, succede che, per la maggior parte, gli uomini attribuiscono il più grande valore proprio all'opinione che gli altri hanno di loro, e si danno da fare per quella più che per ciò che, svolgendosi nella loro coscienza, appartiene loro immediatamente; se, conseguentemente, con un capovolgimento dell'ordine naturale, vedono in quell'opinione il momento reale del loro essere, e considerano quanto si svolge nella loro coscienza un momento puramente ideale; se, insomma, fanno di ciò che è derivato e secondario la cosa principale, e se, quindi, sta loro a cuore, più di ciò che essi sono, la loro immagine nella testa degli altri: ebbene, quell'attribuire valore di bene in sé a qualcosa che non risiede, immediatamente, in noi stessi, è quella stoltezza che fu chiamata vanità, vanitas, a significare il vuoto, la vacuità di un tale atteggiamento. Da quanto si è detto è facile riconoscere in esso un aspetto di quel trascurare il fine a vantaggio dei mezzi che ha un'altra espressione nell'avarizia.
Di fatto, il valore che attribuiamo all'opinione altrui e la costante preoccupazione riguardo a essa superano, generalmente, quasi tutte le motivazioni veramente ragionevoli, sicché quel pensiero si può considerare una specie di fissazione universalmente diffusa o, piuttosto, congenita. In tutto ciò che facciamo l'opinione altrui viene presa in considerazione prima, quasi, di ogni altra cosa; e, se ci riflettiamo attentamente, vedremo che quasi la metà di tutte le ansie e di tutti i timori che ci hanno turbati in tutto il nostro passato nascevano da quella preoccupazione; essa è alla base del nostro orgoglio, così spesso offeso perché così morbosamente suscettibile, della nostra vanità e delle nostre ambizioni, dell'ostentazione del lusso e dell'esibizionismo. Senza quella preoccupazione, quella smania, il lusso sarebbe dieci volte minore; da essa ha origine ogni manifestazione di alterigia, ogni point d'honneur, ogni puntiglio: e quali sacrifici richiede! Presente già nei bambini, e poi in ogni età, giunge però al suo massimo nell'età avanzata, quando, venendo meno la disponibilità ai piaceri sensuali, resta, a dividersi con la vanità e la presunzione il dominio sull'uomo, soltanto l'avarizia. [...]
Ma, a illustrare ancor meglio l'assurdità di quell'esasperata preoccupazione dell'opinione altrui di cui stiamo parlando, non sarà fuori luogo un esempio veramente superlativo di tale stoltezza radicata nella natura umana; è un episodio singolarmente illuminante per il felice incontro delle circostanze e del personaggio, e consente di apprezzare pienamente la potenza di quello stranissimo impulso.
Il passo che segue è tratto dal circostanziato resoconto, uscito sul Times del 31 marzo 1846, dell'esecuzione capitale di Thomas Wix, un garzone artigiano che aveva ucciso, per vendetta, il suo padrone: «La mattina fissata per l'esecuzione il reverendo cappellano del carcere si recò da lui di buon'ora; ma Wix, pur mantenendo un contegno tranquillo, non mostrò alcun interesse per le sue esortazioni: tutto ciò che gli stava a cuore era riuscire a comportarsi col più grande coraggio davanti agli spettatori della sua ignominiosa fine. (...) E gli riuscì. Nel cortile, che doveva attraversare per giungere al patibolo eretto nei pressi della prigione, disse: "Ebbene, presto conoscerò, come ha detto il dottor Dodd, il grande mistero!". Benché avesse le braccia legate, sali senza il minimo aiuto la scala del patibolo, e, giunto sul palco, fece, rivolto agli spettatori, inchini a destra e a sinistra, ai quali la folla radunata rispose con urla di acclamazione e fragorosi applausi (...)». Ecco un magnifico esempio di vanità: uno che ha davanti agli occhi la morte nel suo aspetto più orrendo, e si trova di fronte all'eternità, e non ha altro pensiero che quello dell'impressione che susciterà nella folla dei curiosi e dell'opinione che lascerà di sé nelle loro teste! [...]
Se il condurre un'esistenza appartata esercita un'influenza oltremodo benefica sulla nostra serenità di spirito, ciò dipende, in gran parte, dal fatto che essa ci sottrae a una vita vissuta continuamente sotto gli occhi degli altri, e, conseguentemente, al dover tener continuamente conto della loro eventuale opinione; e, quindi, ci restituisce a noi stessi. Con una vita così eviteremmo moltissime vere e proprie sventure in cui siamo trascinati da quell'aspirazione puramente ideale, o meglio da quella sciagurata stoltezza, ci sarebbe concesso di dedicare molto maggior cura a beni concreti, e potremmo goderne più indisturbatamente».
Arthur Schopenhauer, Il giudizio degli altri, 1851 (in Aforismi per una vita saggia, Rizzoli, 1993, trad. B. Betti).
Il testo esplora con lucidità una dinamica che attraversa tutte le età e tutti i contesti: la centralità dello sguardo altrui nella costruzione del valore personale. Schopenhauer non si limita a descrivere la vanità, ma ne analizza la struttura: l’opinione degli altri diventa una misura interna, capace di influenzare scelte, emozioni, priorità.
La dipendenza dal giudizio esterno non è solo una debolezza: è una forma di investimento. Si lavora, si studia, si consuma, si compete, spesso per ottenere riconoscimento. E quando questo riconoscimento manca, il senso di sé vacilla.
Il testo suggerisce una distinzione utile: ciò che si è per sé e ciò che si è per gli altri. Confondere le due dimensioni significa vivere in una rappresentazione, non in una realtà. La felicità, in questa prospettiva, non si misura in reputazione, ma in qualità dell’esperienza.
Acquista il libro su Amazon. | Torna al Blog di DW. | Home. | Manifesto. | Disclaimer sulle citazioni.