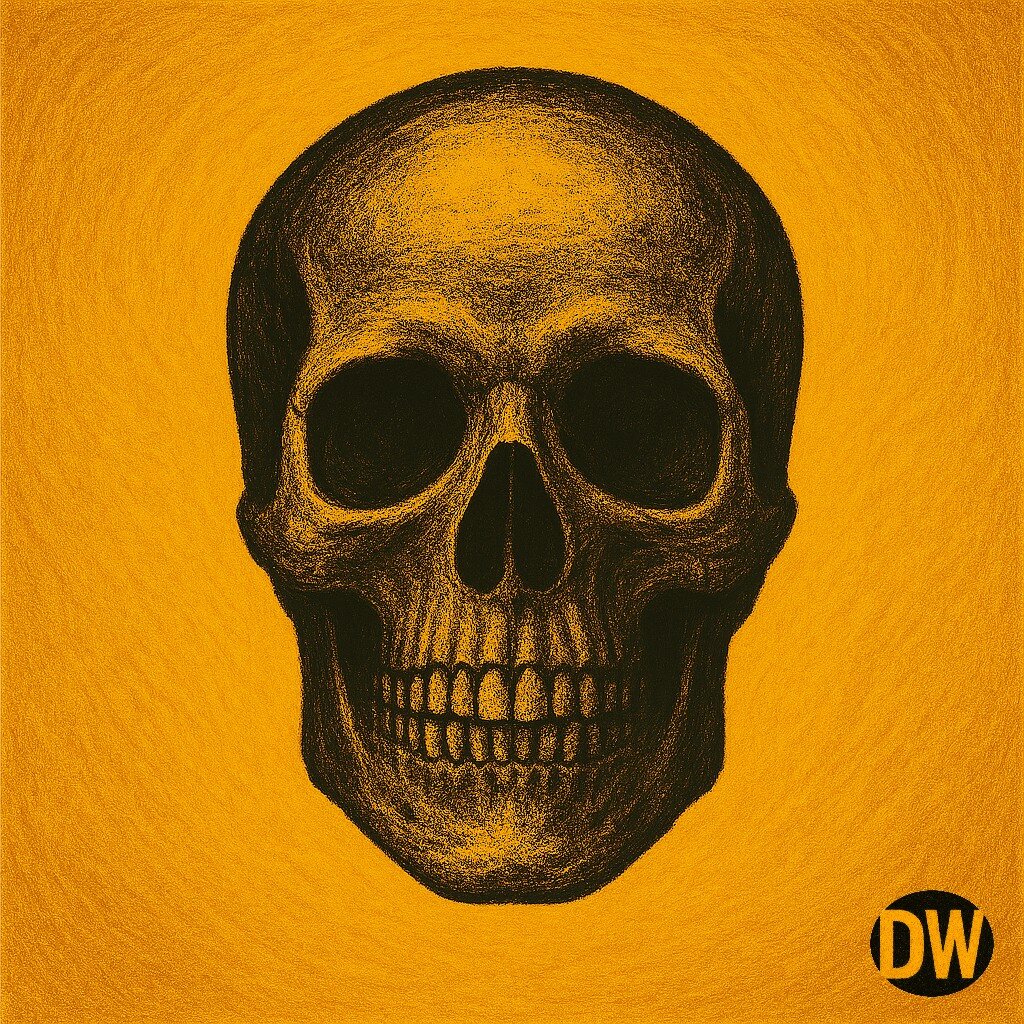«I rapporti fra emozione e cognizione dipendono da quelli che esistono tra la corteccia cerebrale e il sistema limbico, associati tra loro da numerose connessioni nervose. La corteccia cerebrale ha il compito di integrare le reazioni dei nuclei del sistema limbico coinvolti nell'emozione e di paragonarle con quelle che hanno avuto luogo nel passato in occasione di eventi simili: in tal modo le informazioni del presente vengono allacciate a quelle del passato, assicurando una dimensione temporale alla memoria.
L'emozione conferisce così una dimensione calda ai ricordi, fa sì che essi non siano soltanto eventi, ma eventi significativi. L'emozione, inoltre, dà una particolare coloritura individuale ai ricordi facendo sì che essi abbiano un aspetto prevalentemente positivo, come avviene nelle persone ottimiste, oppure negativo, come invece avviene nei depressi: questi, se devono memorizzare una lista di parole ricordano di più quelle dotate di una valenza negativa (infelicità, tristezza, incidente eccetera) rispetto a quelle con valenza positiva (sorriso, gioia, vincita al gioco eccetera). La situazione è invece opposta nel caso degli ottimisti.
I modi in cui le emozioni influenzano le funzioni cognitive (memoria, valutazioni, decisioni eccetera) sono molteplici e non dipendono soltanto da quelle interazioni tra sistema limbico e corteccia appena illustrate, ma anche da numerose modifiche che le emozioni inducono nel nostro corpo. Tali modifiche non hanno soltanto il compito di informare il cervello che il corpo è emozionato, caratterizzando cosi alcune esperienze, ma anche quello di esercitare un effetto sulla memorizzazione delle esperienze, cioè sull'efficienza dei meccanismi della memoria. Ad esempio, sostanze come le endorfine (molecole che esercitano un'azione antidolorifica simile a quella della morfina e che vengono liberate dal cervello in risposta sia a stimoli dolorifici che emotivi) alterano la funzione delle sinapsi nelle reti nervose che registrano le esperienze: un'emozione molto forte, cioè un livello elevato di endorfine, può provocare un'amnesia, fa sì che un'esperienza non venga ricordata.
L'emozione, però, non interviene soltanto in modo diretto sui meccanismi della memoria, agendo sulla biochimica cerebrale, ma anche in modo indiretto, attraverso i messaggi che il corpo emozionato invia al cervello. Ad esempio, è stato appurato che negli animali sottoposti a esperienze ricche di componenti emotive la memorizzazione viene potenziata in quanto il «nervo vago» (che dal corpo invia messaggi al cervello) indica che a livello periferico sono state liberate sostanze tipiche degli stati emotivi «forti»: come l'adrenalina, prodotta dalle ghiandole surrenali.
Si verifica così un circolo vizioso: quando la mente reagisce ad alcune situazioni con un'emozione, il cervello, attraverso i nervi diretti verso la periferia, agisce sul corpo inducendolo a produrre alcune sostanze, come l'adrenalina, in grado di adattare l'organismo alle situazioni di stress, emozioni comprese. L'adrenalina, a sua volta, stimola recettori che, attraverso il nervo vago, giungono al cervello e lo inducono a produrre mediatori nervosi che, appunto, modulano i processi della memoria.
Quando parliamo di emozione e delle sue basi nervose tendiamo a separare, come un tempo fece Cartesio, la vita «animale» da quella «razionale», ritenendo che alcuni aspetti della nostra psiche – l'emozione appunto – abbiano poco a che vedere con le funzioni più «elevate» della nostra mente, con quella razionalità che consideriamo l'aspetto più tipico della mente umana. In realtà, grazie ai rapporti che esistono tra sistema limbico e corteccia cerebrale, l'emozione esercita un effetto molto sottile sul modo in cui valutiamo la realtà, prendiamo decisioni, interagiamo socialmente con le altre persone, com'è evidente da quei casi clinici in cui si verificano lesioni del sistema limbico. Come abbiamo appena osservato, il sistema limbico e la corteccia frontale sono connessi tra loro da numerose vie nervose: se queste vie sono lese, o se è lesa la corteccia frontale, si verificano profonde modifiche della vita sociale e della capacità di prendere decisioni.
Questi problemi non derivano da una perdita dell'intelligenza «razionale», ma da una perdita di quella «emotiva», vale a dire dalla difficoltà di analizzare e valutare diverse alternative o di prendere la decisione giusta in tempi brevi. Queste persone sono in grado di valutare cosa sia o non sia socialmente accettabile ma non sentono, emotivamente parlando, cosa sia giusto o errato. In altre parole, pur sapendo, non provano quelle emozioni che giocano un ruolo centrale in ogni nostra decisione, a partire dall'infanzia. Il bambino che pensa di mangiarsi un cioccolatino, malgrado la proibizione della mamma, sente dentro di sé l'emozione, uno stato indistinto di agitazione, che deriva da una scelta proibita: potrà decidere di mangiare il cioccolatino o di non compiere quest'azione, ma sarà sempre conscio di aver violato od ottemperato a una regola «sociale».
Gran parte delle nostre azioni e decisioni, anche il prendere un semplice appuntamento col dentista, implicano valutazioni emotive: non percepire questa componente «non razionale» può portare a uno stato di indecisione o a non valutare le conseguenze di ciò che si fa, ad avere quelli che la società definisce comportamenti «asociali» o «antisociali».
La conoscenza dell'importanza delle emozioni nel nostro comportamento, in particolar modo per quanto riguarda scelte e decisioni, risale a un caso ormai lontano, quello di un minatore americano che in seguito a una lesione cerebrale smise di essere se stesso e cambiò personalità.
Nel lontano 1848 Phineas Gage fu vittima di uno sfortunato ma indicativo incidente. Gage, che a quei tempi era un giovane di 25 anni, lavorava con altri artificieri alla costruzione della ferrovia attraverso il New England, non lontano da Boston. La strada ferrata doveva attraversare una regione rocciosa ed era necessario fare dei lavori di sbancamento per livellare il terreno. Si trattava di trapanare la roccia, riempire i buchi con polvere pirica, versarvi sopra della sabbia, comprimere il tutto con una bacchetta di ferro e infine fare esplodere la carica attraverso una miccia. Un giorno di settembre del 1848 Gage si distrasse e compresse la polvere pirica con la bacchetta di ferro prima che vi fosse stata versata della sabbia: sfortunatamente la polvere esplose, scagliò la bacchetta in alto e questa, dopo aver colpito la faccia del giovane sotto lo zigomo, penetrò nel cervello, trapassò la volta cranica del povero minatore e atterrò a un centinaio di metri di distanza.
Phineas Gage, evidentemente, doveva avere una tempra fuor del comune: dopo qualche momento di stordimento si allontanò con le sue gambe dal luogo dell'incidente e lo descrisse a viva voce ai suoi compagni e datori di lavoro. Ovviamente dovette ricorrere alle cure di un medico, tale John Harlow, che descrisse dettagliatamente il rapido ricupero della vittima di questa fatalità e il suo ritorno alla «normale vita di lavoro».
Tuttavia, malgrado la pronta ripresa della salute, Gage dimostrò ben presto di non essere più lo stesso uomo di un tempo: benché non presentasse deficit del linguaggio, dei movimenti o dell'apprendimento – fatto insolito, visto che era stata lesa una vasta parte della corteccia che può essere responsabile di queste funzioni, quella frontale – il giovane cominciò ad avere dei problemi sul lavoro.
Prima dell'incidente Gage era una persona calma, giudiziosa, che teneva fede ai suoi impegni, amichevole e simpatica. Dopo l'incidente, come notarono i suoi stessi compagni, «Gage non era più Gage»: era diventato irriverente, capriccioso, blasfemo, privo di senso della responsabilità: non si poteva fare più nessun affidamento su di lui perché non prestava fede ai suoi impegni e non mostrava nemmeno di curarsene molto. I suoi datori di lavoro lo licenziarono e, dopo una vita errabonda, il povero Gage tornò dalla sua famiglia, in California, e trascorse a San Francisco gli ultimi anni della sua esistenza, incapace di rifarsi una vita autonoma. Tredici anni dopo Gage morì: mentre ai tempi dell'incidente egli era stato al centro delle cronache giornalistiche, la sua morte non fece notizia e i medici non ritennero di dover fare un'autopsia, malgrado numerosi neurologi, americani e francesi, avessero discusso del suo celebre caso.
Il caso Gage suscitò ancora qualche polemica tra gli studiosi del cervello, tra cui i celebri neurologi e studiosi del linguaggio Paul Broca e Carl Wernicke, ma poi la vicenda si spense e il cranio dello sfortunato minatore venne affidato al museo anatomico dell'università di Harvard, dove venne custodito, accanto alla bacchetta di ferro che lo aveva trapassato, sino ai nostri giorni. Intorno alla fine del Novecento il «caso Gage» è tornato nuovamente agli onori delle cronache scientifiche in quanto, a distanza di oltre un secolo, è stato riesaminato da un'équipe di neurologi delle università di Boston e dell'Iowa che, sulla base dei fori d'entrata e d'uscita nel cranio, perfettamente visibili e conservati, hanno simulato al computer il percorso della bacchetta di ferro, individuando l'area della corteccia frontale lesa in quella sfortunata giornata del 1848.
Si è così riusciti a chiarire i motivi del bizzarro comportamento del giovane minatore in seguito all'incidente: dopo aver delimitato attraverso una simulazione al computer l'area interessata da lesioni del genere, i neurologi statunitensi sono arrivati alla conclusione che la lesione cerebrale di Phineas Gage aveva interessato quella parte della corteccia frontale che media gli aspetti emotivi con quelli cognitivi del comportamento, traducendosi, dal punto di vista sociale, nelle cosiddette «scelte razionali».
Ma il «caso Gage» ci indica anche che la nostra individualità, le radici dell'io, affondano in vari aspetti delle caratteristiche naturali del nostro cervello e nelle tappe del suo sviluppo».
Alberto Oliverio, La mente, 2001 (Rizzoli).
Il testo mostra come le emozioni non siano un accessorio della mente, ma una parte attiva del processo decisionale. Le scelte, anche quelle quotidiane, passano da un circuito che coinvolge corpo, memoria, contesto e valutazione emotiva.
La storia di Phineas Gage lo chiarisce: non basta sapere cosa è giusto, bisogna anche sentirlo. Quando questa connessione si interrompe, la razionalità non basta più.
Il comportamento umano non si spiega solo con la logica. Serve osservare, confrontare, chiedersi cosa manca. E continuare a farsi domande, anche quando la risposta sembra ovvia.
Acquista il libro su Amazon. | Torna al Blog di DW. | Home. | Manifesto. | Disclaimer sulle citazioni.