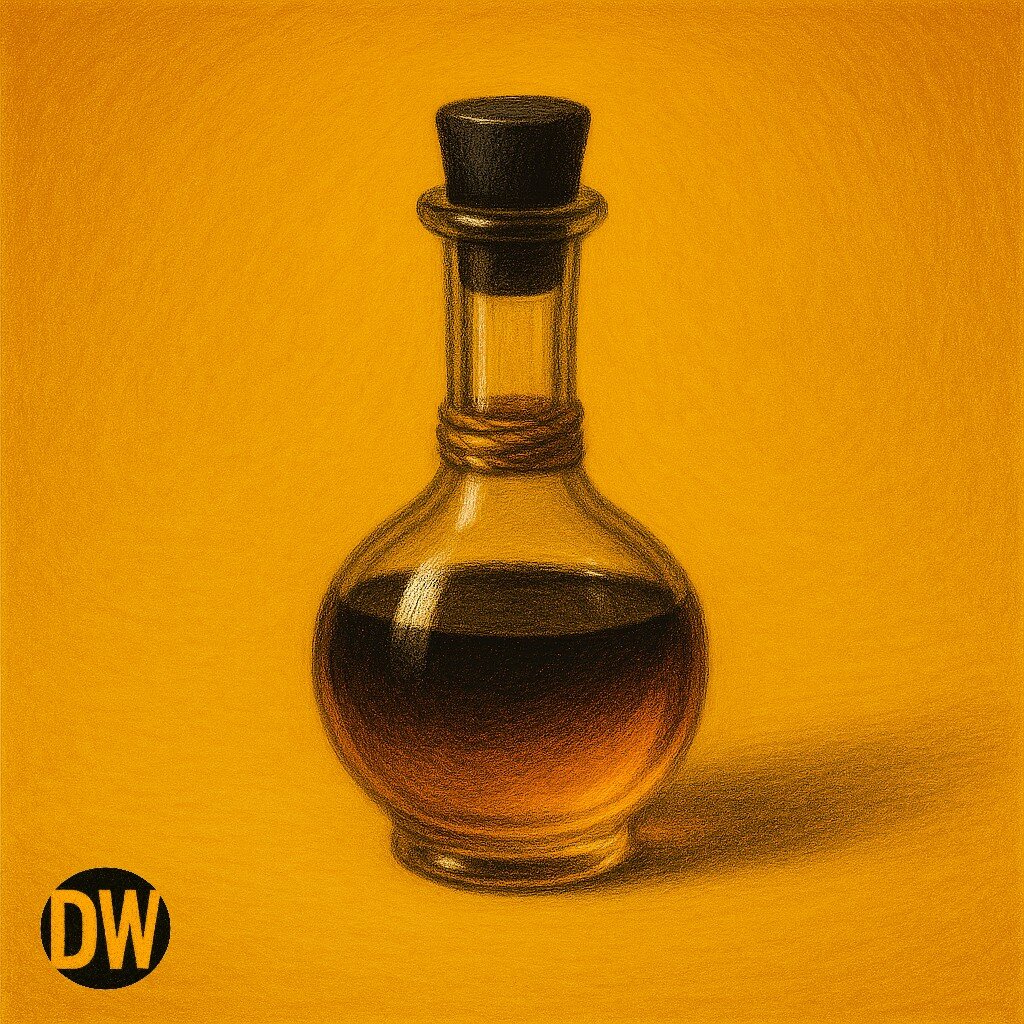«Il Tempio del Popolo era una setta nata a San Francisco, dove reclutava adepti fra la popolazione povera. Nel 1977 il Rev. Jim Jones, che era l'indiscusso capo politico e spirituale del movimento, si trasferì col grosso dei seguaci in Sud America, nelle giungle della Guyana, dove fondò l'insediamento di Jonestown. Lì essi rimasero in relativa oscurità fino al 18 novembre 1978, quando quattro membri di una commissione d'indagine inviata a Jonestown dal Congresso furono uccisi mentre cercavano di ripartire in aereo. Convinto che sarebbe stato arrestato come mandante del delitto e che ormai la sorte della sua setta era segnata, il Rev. Jones cercò di controllare a suo modo la fine del Tempio del Popolo: raccolta intorno a sé tutta la comunità, chiamò tutti al suicidio in un atto collettivo di autodistruzione.
La prima a rispondere all'appello fu una giovane donna che si avvicinò con calma al vaso della bevanda avvelenata, ne somministrò una dose al suo bambino, una per sé e si sedette nel prato ad aspettare la morte, sopravvenuta con convulsioni in qualche minuto. Gli altri seguirono a turno con regolarità. Pochissimi fuggirono: dalla loro testimonianza sappiamo che qualcuno oppose resistenza, ma la grande maggioranza delle 910 persone andò alla morte con ordine e del tutto volontariamente.
Le notizie da Jonestown sconvolsero un po' tutti. Per giorni fummo bombardati da notiziari e servizi giornalistici e l'argomento occupava le conversazioni. Su tutte dominava una domanda: quale può essere la causa di tutto ciò? Si sono proposte varie spiegazioni. Alcune insistevano sul carisma di Jones, un uomo che era riuscito a farsi amare, obbedire e rispettare come un salvatore, un padre, un monarca assoluto. Altre spiegazioni mettevano in rilievo il tipo di persone che si erano lasciate attrarre dalla setta: per lo più individui senza istruzione, poveri, disposti volentieri a rinunciare alla libertà di pensiero e di azione in cambio della sicurezza di un posto dove qualcuno decidesse per loro. Altre analisi sottolineavano l'aspetto del fanatismo religioso, con una fede assoluta nel capo della setta. Senza dubbio questi elementi hanno il loro peso per spiegare quello che è successo, ma non mi sembrano sufficienti. Dopo tutto, il mondo è pieno di sette di fanatici guidati da figure carismatiche, né sono mai mancate nel passato combinazioni di circostanze analoghe. Eppure non si incontrano episodi nemmeno lontanamente paragonabili a quello di Jonestown. Dev'esserci qualche altro fattore decisivo.
A metterci sulla strada è una domanda particolarmente rivelatrice: se la comunità fosse rimasta a San Francisco, l'ordine del Rev. Jones sarebbe stato obbedito? Lo specialista che ha conosciuto più da vicino la setta di Jones non ha dubbi in proposito. Intervistato subito dopo l'avvenimento, Louis Jolyon West, preside di psichiatria e scienze biocomportamentali all'Università della California (Los Angeles), un'autorità nello studio delle sette, che aveva osservato il Tempio del Popolo per otto anni prima dell'emigrazione nella Guyana, dichiarava: «In California non sarebbe successo, ma là vivevano totalmente estraniati dal resto del mondo, nella giungla e in un paese ostile».
Benché sia passata quasi inosservata nella massa dei commenti sulla tragedia, l'osservazione di West mi sembra fondamentale per capire l'acquiescenza di massa all'ordine di suicidio.
A mio modo di vedere, l'atto che più d'ogni altro nella storia della setta ha contribuito a determinare quel risultato risale a un anno prima, col trasferimento del Tempio del Popolo in mezzo alla giungla, fra gente diversa per lingua e costumi. Se vogliamo credere a quello che si racconta sulla perversa genialità del Rev. Jones, questi doveva avere molto chiaro l'impatto che una mossa del genere avrebbe avuto sui suoi seguaci. Da un momento all'altro si trovarono in un luogo totalmente sconosciuto nella foresta tropicale, dove non c'era nulla che si potesse lontanamente ricollegare alle loro esperienze precedenti in California. Da qui l'incertezza, grande alleata del principio di riprova sociale. Come abbiamo visto, è proprio quando sono incerte sul da farsi che le persone guardano alle azioni degli altri per decidere che condotta tenere. E, non dimentichiamo, altri che siano simili a loro.
Ecco che in Guyana i membri della setta, disorientati e incerti, non trovavano modelli simili a loro altro che fra i membri della comunità.
La decisione sul comportamento da tenere veniva così ad essere determinata in misura eccessiva da ciò che facevano gli altri membri della setta. Viste sotto questa luce, la terribile calma disciplinata e l'assenza di panico con cui questa gente faceva la fila per la razione di veleno diventano più comprensibili. Non erano ipnotizzati da Jones, ma erano stati convinti, in parte da lui ma soprattutto dalla riprova sociale, che il suicidio era il comportamento giusto. L'incertezza che di sicuro hanno provato sentendo l'ordine di suicidio in massa deve averli spinti a guardarsi intorno per capire quale fosse la reazione più adeguata. E guardandosi intorno hanno trovato due segnali ben precisi e convergenti.
Il primo era dato dal gruppo dei più fanatici, che accorrevano senza indugio a prendere le dosi di veleno. Fossero istruiti da Jones a dare l'esempio o lo facessero spontaneamente, l'effetto psicologico dev'essere stato potente: se la notizia di un suicidio in prima pagina può indurre al suicidio dei perfetti estranei, si immagini quanto più convincente possa essere questo atto eseguito da un compagno di fede in un luogo come Jonestown.
L'altra riprova sociale veniva dalla reazione della stessa folla. Date le condizioni, immagino che si sia verificato su larga scala uno di quei fenomeni di ignoranza collettiva che spesso coinvolgono i testimoni oculari di casi d'emergenza: ognuno osservava il comportamento degli altri e, vedendo intorno a sé una calma apparente – poiché anche ciascuno degli altri, invece di reagire, si guardava intorno per capire la situazione – "veniva a sapere" che fare pazientemente la fila era il comportamento giusto. Da un segnale di gruppo così frainteso ma convincente possiamo giustamente aspettarci un risultato come la spettrale compostezza delle file di cadaveri scoperte a Jonestown.
Dal mio punto di vista, la maggior parte delle analisi si è troppo focalizzata sulle qualità personali del Rev. Jones. Pur essendo innegabili le sue doti di capo carismatico, il suo potere nasceva, più che dal suo stile personale, dall'aver capito con chiarezza alcuni principi psicologici fondamentali. Nessun capo può sperare di persuadere direttamente tutti i membri del gruppo, ma il fatto che sia riuscito a convincerne una frazione considerevole basta a convincere il resto. I capi più efficaci sono quelli che sanno predisporre condizioni di gruppo tali che il principio di riprova sociale operi con la massima intensità e a loro favore.
Il colpo da maestro in questo caso fu la decisione di Jones di sradicare la comunità dall'ambiente urbano dov'era nata, per trapiantarla nella foresta tropicale, dove le condizioni di incertezza e isolamento avrebbero potenziato quel meccanismo psicologico come in nessun altro luogo».
Robert B. Cialdini, Le armi della persuasione, 1984 (Giunti, trad. G. Noferi).
Un esempio quotidiano del principio di riprova sociale si osserva nel contesto della ristorazione: un locale affollato viene generalmente percepito come sinonimo di qualità, mentre uno vuoto suscita diffidenza, anche in assenza di informazioni oggettive. In situazioni di incertezza, il comportamento degli altri diventa un indicatore di scelta, spingendo a conformarsi alla maggioranza.
L’episodio di Jonestown, analizzato da Cialdini, mostra come il principio di riprova sociale possa diventare un potente meccanismo di persuasione in condizioni di isolamento, che acuisce la sensazione di incertezza. Non fu solo il carisma di Jim Jones a determinare la tragedia, ma la dinamica psicologica per cui, in assenza di punti di riferimento esterni, le persone guardano al comportamento degli altri per decidere come agire. In un contesto chiuso e omogeneo, questo effetto si amplifica fino a rendere accettabile persino un atto estremo come il suicidio collettivo.
Leggi anche #026 | Il giudizio degli altri di Arthur Schopenhauer.
Acquista il libro su Amazon. | Torna al Blog di DW. | Home. | Manifesto. | Disclaimer sulle citazioni.